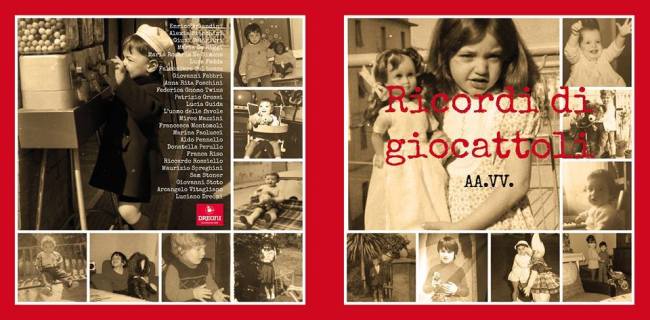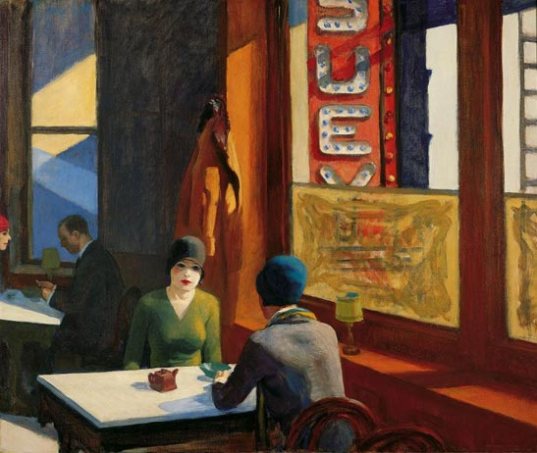Guardare una fotografia e provare a leggerla ricamandoci sopra un racconto breve. E’ quello che ho cercato di fare un anno fa quando ho pensato a “In un campo d’orzo e di papaveri”, premiato domenica 19 ottobre 2014 a Roseto Valfortore (FG), come racconto vincitore del II posto della VII edizione del “Premio Lupo”, sezione letteraria, promosso dal comune di Roseto Valfortore, sostenuto da buona parte dei comuni del comprensorio del Subappennino Dauno, con il partenariato dell’Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Spettacolo della Regione Puglia e il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Foggia.
Il sogno di Lauretta è quello di riuscire a intrecciare una coroncina di papaveri senza rovinarne la delicata sericità. La bimba riuscirà nel suo intento, e il braccialetto di fiori da lei creato con amore e altrettanta delicatezza diventerà per sua zia Maria Luisa, alla ricerca di una vita personale maggiormente soddisfacente, a cui il dono è riservato, metafora e simbolo beneaugurante di un futuro migliore.
Cornice del racconto la terra forte e dura di Puglia, ricca e capace di inaspettati atti di generosità.
Buona lettura
In un campo d’orzo e di papaveri
La bambina si guardò attorno circospetta, temendo che qualcuno potesse rimproverarla per la sua sparizione ingiustificata; poi sospirò silenziosamente, rinfrancata da ciò che le compariva davanti. Attorno a lei c’era soltanto la distesa sconfinata di quel campo d’orzo inselvatichito, vivificato dal tripudio di papaveri e fiori selvatici che erano riusciti a sopraffarne la rassegnata uniformità. Ricacciando indietro le ciocche ribelli sfuggite alle treccine castane, si chinò a raccogliere quanti più fiori rossi poteva, noncurante dei cardi e dell’ortica che le insidiavano le gambette nude, a malapena protette dal vestitino di cotonella sottile.
I papaveri erano i fiori che preferiva in assoluto: belli, slanciati, setosi. Peccato che durassero il tempo di un respiro. Decise, tuttavia, di portarli a casa con sé per provare a intrecciarli in una coroncina come aveva visto fare a Natalina, la sua compagna di banco, con una manciata di pratoline. Quando le aveva detto della sua idea l’altra l’aveva guardata con un’ombra di compatimento.
– Non si può – aveva, poi, replicato con fare saccente.
– Perché no? – aveva insistito lei, suo malgrado dispiaciuta dal tono altezzoso dell’altra.
Natalina l’aveva squadrata con sufficienza se possibile ancora maggiore.
– I papaveri sono troppo delicati e muoiono presto – aveva sentenziato seccamente. Abbandonandola di scatto per raggiungere un gruppo di altre bambine che, in cerchio e tenendosi per mano, avevano preso da poco a intonare “La solitudine si deve fuggire”.
Lauretta era rimasta seduta su una panchina del cortile della scuola, all’ombra traforata di un albero di acacia, riflettendo a lungo su quanto l’amica le aveva svelato, le gambette penzoloni altalenanti e il capo chino. Per quella mattina non c’era stato gioco che l’avesse tentata abbastanza da farle lasciare la posizione rinunciataria in cui si era caparbiamente trincerata.
Il gracchiare lontano di una cornacchia la fece tornare al presente di quell’afosa giornata di principio d’estate. Guardando i papaveri raccolti decise che potevano bastare e si buttò a peso morto tra l’erba alta del campo semiabbandonato insensibile ai minuscoli abitanti che ne popolavano le nutrite retrovie. Sopra di lei il cielo, al mattino di un azzurro intenso, aveva preso un colore celestino indefinito, certamente dovuto al gran caldo. Con ponderatezza si scelse una nuvola dai contorni insoliti a cui aggrapparsi per poter fantasticare in libertà.
– Lauretta!
Il grido femminile, lontano ma non abbastanza da non essere da lei percepito con chiarezza, spezzò quell’incantesimo breve. Sollevandosi appena sui gomiti la bambina intravvide una donna vestita completamente di nero, dal fazzoletto che portava in testa al gonnone informe che ne avvolgeva la figura appesantita dallo scorrere impietoso del tempo e dalle tante fatiche domestiche. Sua madre, mani ai fianchi, la stava cercando, e non sembrava per niente contenta di non riuscire a scorgerla da nessuna parte. Riflettendo febbrilmente sul da farsi, Lauretta traccheggiò tra l’idea di riemergere dal microcosmo brulicante in cui si era crogiolata con indolenza sino a pochi istanti prima e quella di aspettare che la donna rientrasse nell’austera casa colonica oltre il campo, piombandole d’improvviso e come per incanto davanti con la cesta di vimini ricolma di uova e l’aria vaga che assumeva quando voleva dare a intendere agli altri di essere qualcuno che non era.
La cesta di vimini, oggetto delle richieste materne, era a pochi passi da lei, invasa da una colonia di formiche operaie ma il suo contenuto le pareva ancora indenne e tanto le bastava. Ricadendo all’indietro tra le sterpaglie Lauretta decise di indugiare per un altro po’, cercando di resistere stoicamente all’intraprendenza di un grillo che aveva preso a passeggiarle sul braccio e non voleva saperne di andar via.
Maria si guardò attorno, tentando di mitigare la luce abbacinante del sole proteggendosi gli occhi con una mano. Di quella figlia pestifera non c’era traccia. Le sembrò di scorgere qualcosa a ridosso del vecchio spaventapasseri ma poi decise che era solo un cardellino alla ricerca di qualche seme da becchettare e lasciò perdere.
A casa avrebbero fatto i conti non appena Lauretta si fosse degnata di farvi ritorno. Si sentì quasi male al ricordo di tutto il daffare in sospeso per la promessa di sua sorella. Mancavano due giorni all’evento e ogni cosa, come al solito, era lì a gravare sulle sue spalle.
Arrancando sulle zolle di terra arida si avviò verso l’aia, a quell’ora deserta, detergendosi le stille di sudore che avevano preso a colarle abbondanti sul volto per il calore solare attirato da tutto quel nero che la ammantava a celebrazione doverosa dell’ultimo lutto familiare.
Lauretta sbirciò con un velo di colpa sua madre attraverso un ciuffo di gramigna e fece per alzarsi ma qualcosa la convinse a non mostrarsi ancora. In quel pezzo di terra incolta non era la sola ad essersi nascosta agli occhi di Maria.
– Vattenne, vai via da me, – era il grido accorato e sommesso di una donna giovane, sua zia Maria Luisa, vestita come l’altra di nero, i capelli acconciati in una crocchia castana sulla nuca appena un po’ disfatta, come alla fine di una lunga giornata laboriosa.
Lauretta non capiva con chi ce l’avesse, fino a quando un uomo dai capelli chiari e dalle braccia muscolose da gran lavoratore non le si affiancò velocemente. Era Vincenzo, un bracciante del paese.
– No che non me ne vado, o vuò capì? – l’apostrofò con rudezza, prendendola per le braccia e costringendola a guardarlo negli occhi – Tu, quello, non lo devi sposare!
Maria Luisa lo fissò con aria dolente e non ebbe il coraggio di replicare nulla. I suoi occhi parlavano benissimo da sé. A un certo punto, però, decise di scrollarsi di dosso quella sorta di trance in cui era caduta e, sia pure a malavoglia, si divincolò dalla presa dell’altro e dal suo abbraccio possente, riuscendo a scappar via verso la masseria. Il gigante biondo si lasciò allora cadere come privo di forza contro il tronco nodoso della quercia secolare che li aveva accolti entrambi sotto la sua provvidenziale ombra.
Lauretta restò acquattata tra le erbe a poca distanza da lui, sperando che l’altro sparisse presto; valutando, intanto, con tutta la consapevolezza infantile di cui era capace, quanto la sua punizione sarebbe stata proporzionale al ritardo accumulato.
Con un guizzo repentino l’uomo si sollevò in piedi facendole mancare un battito, guardandosi attorno alla ricerca di qualcosa (forse un ripensamento retrospettivo dell’amata?) che non riuscì a scorgere da nessuna parte. Allora, con un gran sospiro, si rassettò alla bell’e meglio l‘abito da lavoro che indossava, andando via a spalle curve in direzione dell’abitato, dopo aver ripescato, ben mimetizzata dietro un rovo di more al limitare della carreggiata, una bicicletta vetusta.
Fu soltanto allora che Lauretta, dando fondo a tutto il fiato che aveva in corpo, corse verso casa, i papaveri raccolti celati nel cestino assieme al suo prezioso contenuto.
– Dov’eri finita?
La mamma era palesemente di malumore in quella cucina di campagna piena di odori di cibo; aiutata dalla nonna, stava sgranando piselli in una coppa di ceramica sbreccata, mentre le zie Annarella e Maria Luisa provvedevano a lavorare su una spianata di legno un’enorme quantità di massa per il pane.
Lauretta decise di non rispondere. Qualsiasi cosa avesse deciso di dire sarebbe stata contrastata dalla sua interlocutrice, quindi si affiancò alla nonna ben decisa a darle una mano, le manine magre tradite da inconfondibili striature rossastre che fecero corrugare lo sguardo all’anziana ma non produssero fortunatamente altro effetto.
– Ci voglio fare una coroncina per la festa di domenica – le confidò a bassa voce in uno sprazzo di sincerità. La nonna scosse il capo con disapprovazione.
– A lutto, stiamo. Il rosso non va bene
La bambina non ne era pienamente convinta.
– Nemmeno per una coroncina o un braccialetto in un giorno di festa? – chiese mortificata.
Nonna Fonzina questa volta la guardò con reale durezza e con un tono appena al di sopra di quello usato solitamente le replicò stizzita
– Il rosso è il colore del demonio – Chiudendo, per il momento, la questione.
Preparare una festa di fidanzamento non era cosa semplice per gente di campagna come loro. E tuttavia il gioco valeva la candela perché Maria Luisa si sarebbe imparentata con una famiglia benestante come quella del Contini, macellai da tre generazioni. Il matrimonio, combinato per il tramite di Don Marcuccio, sensale, era da subito apparso come una manna dal cielo per tutti loro. Antonio Contini non era propriamente un pezzo di marcantonio. Di aspetto assai modesto, di contrasto con il lavoro intrapreso in paese dalla sua famiglia, dava l’idea di volare via col primo colpo di vento; ed era certo che più di una delle sue profferte matrimoniali fosse stata rifiutata da altrettante ragazzotte del posto, che avevano visto la prospettiva di accasarsi con lui come il fumo negli occhi. Maria, invece, l’aveva da subito considerata una prospettiva unica e invidiabile per elevare il tenore della propria famiglia per il tramite dell’avvenenza e della gioventù della sorella minore. Dandosi da fare, con ogni mezzo, per condurre quest’ultima per la propria strada.
– Ma io non gli voglio bene …, – aveva protestato accorata la ragazza
– L’amore verrà dopo, – le aveva replicato prontamente lei. L’amore, quello fatto di sentimenti e slanci d’animo, era cosa da canzonette e non per faticatori come loro.
– Pare un morto vivente, davvero. Nessuna l’ha voluto, perché dovrei pigliarmelo proprio io? – aveva continuato l’altra senza demordere, nel disperato tentativo di scampare a quella condanna all’ergastolo
Maria l’aveva guardata cupamente
– Maria Luì, lo vuoi capire o no che senza dote o corredo non ti si marita nessuno? Resterai zitella o sposerai un morto di fame ccume annuie!
L’altra aveva spavaldamente alzato la testa.
– E che m’importa? Vado a servizio in città …
– E allora vacci subito, intesi? Sei una svergognata ingrata … – aveva inveito sua sorella e una vena le si era d’improvviso gonfiata al collo, facendo presagire il peggio.
Quella sera era finita davvero male, Lauretta lo ricordava ancora, con sua zia che, in lacrime, era scappata di notte nei campi e non se n’era saputo più nulla fino al mattino dopo, quando suo padre, con infinita pazienza, aveva ripescato sua cognata in un casolare abbandonato riportandola a casa.
A riequilibrare definitivamente le sorti ci aveva pensato il destino con tragica tempestività.
Zio Michelino era caduto in un pozzo perdendo la vita nel tentativo di appurare se poteva ancora fornire acqua e la carenza di quel paio di braccia maschili oramai irrimediabilmente perse si era subito palesata attraverso una montagna di spese e debiti accumulati con sconcertante facilità a cui i Contini, per intercessione di don Marcuccio, si erano offerti con premura di far fronte in men che non si dica.
Maria si era chiusa in camera con Maria Luisa nel tentativo di farla ragionare mentre il resto della famiglia sedeva attorno al tavolo rettangolare senza avvertire più appetito, incapace di consumare anche un solo boccone dell’opulento pasto di riconsolo, offerto, come tradizione, da amici e parenti per la perdita del pover’uomo.
Nonna Fonzina, zia Annarella, suo padre, lei e suo fratello Lino avevano assistito in silenzio, seduti a cena, alla disperazione della loro zia più giovane, fino a quando suo padre, infastidito o forse imbarazzato da tutto quel clamore in una sera che avrebbe dovuto essere di raccoglimento per l’intera famiglia, era uscito di casa nella notte a fumare una Nazionale dall’odore pessimo. Avuto il permesso di alzarsi da tavola per riordinare e conservare gli avanzi di quella cena sfortunata i restanti convitati avevano seguito il suo esempio senza proferire parola. In barba alle occhiatacce della nonna, Lauretta aveva poggiato un orecchio sulla porta della camera da letto dei suoi per cercare di carpire l’epilogo di quella sceneggiata familiare ma non c’era riuscita. A un certo punto, però, la zia ne era uscita di botto, gli occhi arrossati per il lungo pianto, precipitandosi fuori verso la tettoia dove d’inverno conservavano i ciocchi di legno per il camino, e lei l’aveva istintivamente seguita. L’aria di quella serata di fine maggio era ferma e carezzevole. Lauretta le si era avvicinata con un po’ di timore temendo di essere scacciata, ma la zia le aveva sorriso tra le lacrime e l’aveva stretta a sé quasi a confortare se stessa attraverso il calore autentico e generoso di quel corpicino infantile visibilmente in pena per lei.
Scrutando l’oscurità erano rimaste abbracciate a lungo, sedute su ciò che rimaneva di un tronco di ulivo, sradicato qualche settimana prima dalla buonanima di Michele perché quasi del tutto secco. Quando la luna aveva fatto capolino tra il fogliame dei pochi alberi a confine della costruzione, la zia l’aveva presa in braccio e l’aveva riportata dormiente in casa adagiandola sul lettino nella sua stanzetta.
L’indomani suo padre, di ritorno dal paese vestito dell’unico abito buono che possedeva, aveva annunciato a tutti l’avvenuto fidanzamento tra la cognata e Antonio Contini mentre l’interessata, a capo chino, ne prendeva ufficialmente atto con occhi lucenti ma senza versare altre lacrime.
Due giorni alla festa e ancora tantissime faccende da portare a termine.
Maria se lo ripeteva tra sé e sé di continuo, nel vano tentativo di darsi forza e nessuno osava farle da contrappunto vocale, prestando, tuttavia, senza risparmio le proprie energie per la riuscita di quell’avvenimento memorabile.
La domenica arrivò in un baleno accolta con ansia da tutti sin dalle prime luci dell’alba in piedi, ciascuno con un compito ben preciso cui adempiere. L’aia era stata svuotata e debitamente ripulita da suo padre e dal modesto contributo di suo fratello Lino, la tavolata apparecchiata come d’uso per le festività solenni all’ombra di una tettoia ombreggiata da filari d’uva per fornire frescura sufficiente al banchetto dei promessi. Le vivande, preparate per tempo, erano state allineate su ogni superficie libera dell’enorme cucina e in parte anche della stanza da letto dei padroni di casa, lustrata a specchio e prontamente rimessa in ordine, la coperta di broccato sormontata da quella intagliata sul letto matrimoniale rifatto da sua madre alla perfezione.
Maria Luisa era un incanto nell’abitino cucitole dalla sarta di paese; nero regolamentare, manco a dirlo, ma ingentilito da una scollatura a cuore e un vitino sottile con una gonna più ampia di quelle da lei di solito indossate. A Lauretta pareva una delle cantanti del festival di Sanremo sbirciate con curiosità sul giornaletto della signora Irma, bolognese, su cui questa e la mamma avevano scelto per la promessa sposa un modello degno delle circostanze.
La giornata era andata avanti senza scossoni, seguendo un copione prestabilito elaborato con sapiente lungimiranza. Gli ospiti, accolti con deferenza, erano stati fatti accomodare in casa per i primi scambi di convenevoli e poi condotti sotto il famoso pergolato. Maria Luisa e Antonio Contini erano seduti al centro, affiancati ciascuno dai personaggi principali della propria famiglia di origine come in una bizzarra prova generale del pranzo di matrimonio che si sarebbe celebrato a meno di un mese. Lauretta aveva contato una quindicina di invitati, intristendosi al pensiero che nessuna delle donne adulte presenti indossasse abiti dai colori vivaci, beneauguranti, e aveva fatto onore al banchetto, notando, invece, come la zia Maria Luisa spilluzzicasse di malavoglia ciò che con abbondanza sua sorella si affannava a offrirle invitandola, con occhiate più che eloquenti, a servirsene.
Lei e Lino avevano anche provato a familiarizzare con i bambini Contini ma senza successo; le due femminucce in abiti pastello ed enormi fiocchi di nylon tra i capelli, non si staccavano dalle gonne delle rispettive madri e l’unico maschio, dell’età apparente di quindici anni, non aveva intenzione di sporcarsi di terriccio e di pagliuzze dorate il vestito a giacca scuro come, invece, era capitato a Lino. Con sguardo furbo la bimba constatò come l’abbondante e generoso vino rosso e la ratafìa ghiacciata stessero facendo effetto sugli ospiti, decidendo che era arrivato per sé il momento di allontanarsi dalla tavolata, sentendosi come un cuccioletto legato alla catena a cui sia finalmente stata offerta la possibilità di sgranchirsi un po’ le zampe da un padrone severo e intransigente. Le era venuta un’idea luminosa ed era sicura che almeno qualcuno avrebbe gradito la sua sorpresa. Vi si era esercitata per giorni e giorni con risultati eccellenti che non vedeva l’ora di mostrare a tutti Inciampando nel vestitino a sbuffo, grazioso ma scomodo per una bambina en plein air come lei, si spinse coraggiosamente fino al primo ciuffo di papaveri rossi spuntato a ridosso della campagna. Con delicatezza ne colse la giusta quantità, stando attenta a non macchiarsi e a non sgualcirne i petali teneri e impalpabili; poi, col suo bottino si sedette all’ombra della quercia imponente da lì poco distante. Con grande abilità ne intrecciò le corolle riuscendo a non rovinarne nessuna, decidendo di regalare la coroncina di fiori a Maria Luisa. Era sicura che l’avrebbe resa meno triste, forse addirittura più felice.
Due sagome note intrecciate in un abbraccio attrassero la sua attenzione e lei si stropicciò gli occhietti stanchi per il timore di aver frainteso.
Con grande stupore vide sua zia ricambiare inequivocabilmente le affettuosità del gigante biondo e muscoloso baciandolo su una guancia. Questi, allora, la prese per mano aiutandola a salire su un camioncino malmesso poco distante. Un unico attimo di indecisione, poi un’idea veloce come un lampo in un cielo d’estate.
– Zia, aspetta!
Lauretta corse a perdifiato come in quella mattinata lontana ma questa volta per raggiungerli, pronta a consegnare il suo dono campestre con infantile determinazione. I due amanti si volsero di scatto verso di lei, sorpresi, e sua zia, già di lato al suo cavaliere, si sporse dal finestrino e le accarezzò il visetto intelligente sorridendole come per scusarsi, con un luccichio insolito negli occhi che le fece capire che quello era un addio.
Lauretta le tese seria la ghirlandina di papaveri e l’altra l’afferrò veloce con uno sguardo luminoso, ben diverso dall’espressione incolore degli ultimi giorni. Poi le mandò fugace un bacio prima di stringersi al suo cavaliere. L’automezzo si allontanò rombando, sollevando una nuvola di polvere che fece tossire per qualche istante la bimba ma non la intimorì.
Quando li vide scomparire dietro il lungo filare di pini marittimi che delimitava la carreggiata Lauretta s’incamminò sulla strada del ritorno stringendo in pugno l’unico fiore rosso sfuggito al suo capolavoro, con sguardo pensieroso. Di una cosa, però, era abbastanza sicura. I papaveri erano troppo incantevoli per appartenere al demonio. Potevano soltanto essere fiori di angeli provvidenziali se erano riusciti a restituire il sorriso a sua zia. Gongolò al pensiero piacevole di quanto quest’ultima avesse apprezzato il suo braccialetto. Le avrebbe certamente portato fortuna, si disse convinta. Questo pensiero la confortò e la rese più serena.
A pochi passi da lei, al centro dell’aia attorno alla lunga tavolata ancora imbandita a festa, c’era qualcuno che discuteva con concitazione. Con un sussulto leggero lei trasalì credendo di saperne il perché ma non indietreggiò.
Vi si avvicinò, invece, a fronte alta; pian piano, con coraggio e calma estremi, pronta come non mai ad affrontare i rimproveri di sua madre.
Il suo bel vestito della festa era irrimediabilmente macchiato di verde e di vermiglio, ed era una realtà, ma a lei questo poco importava. Attorno a sé avvertiva ancora, forte e persistente, la fragranza discreta dei fiori rossi di campo magicamente da lei intrecciati l’uno all’altro, assieme a un nuovo e misterioso profumo di amore, percepito con lievità di bimba sensibile e da subito riconosciuto e accolto nel suo piccolo cuore.
Lucia Guida

photo by Jarmilla