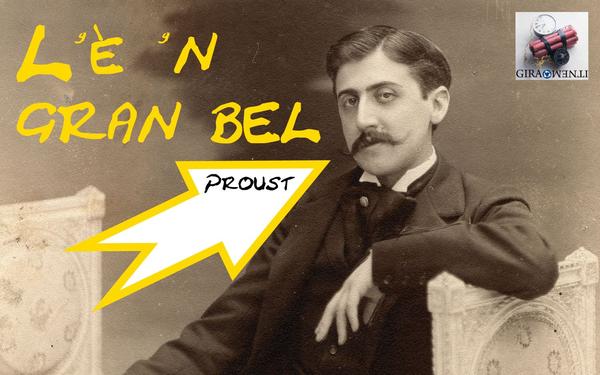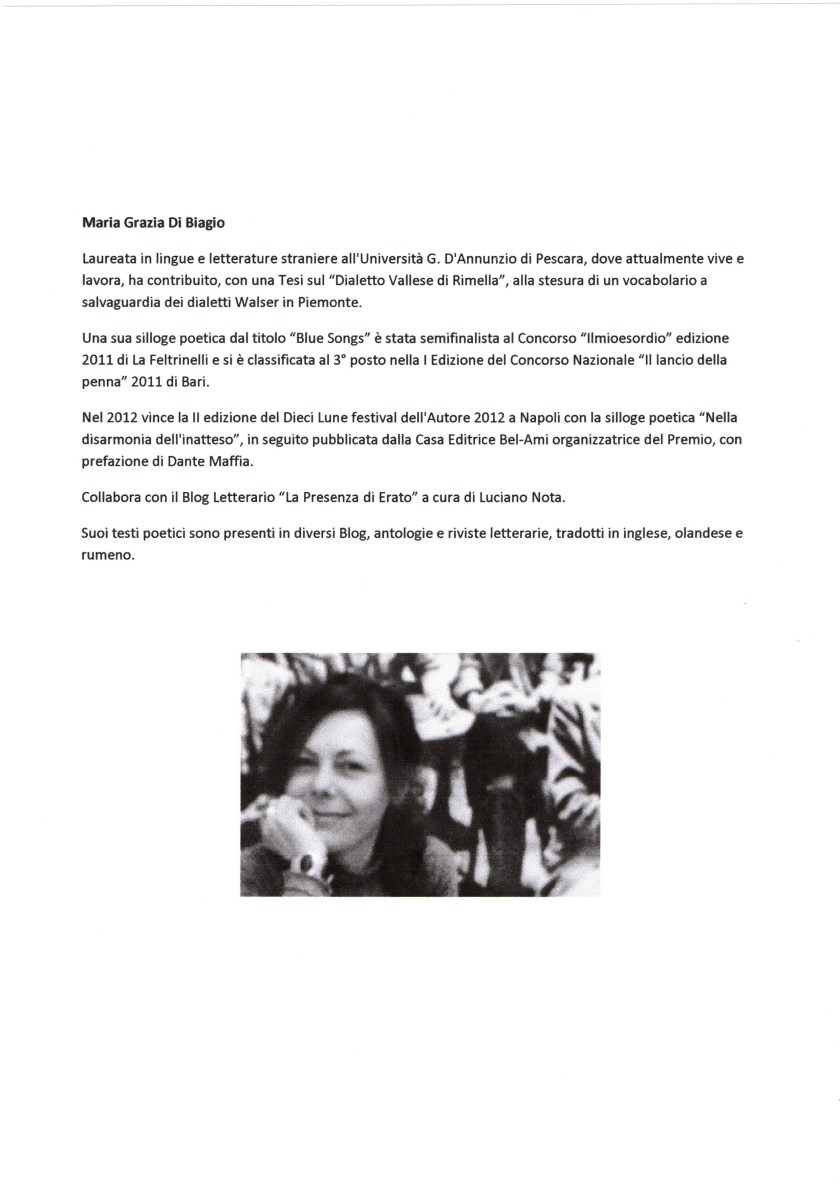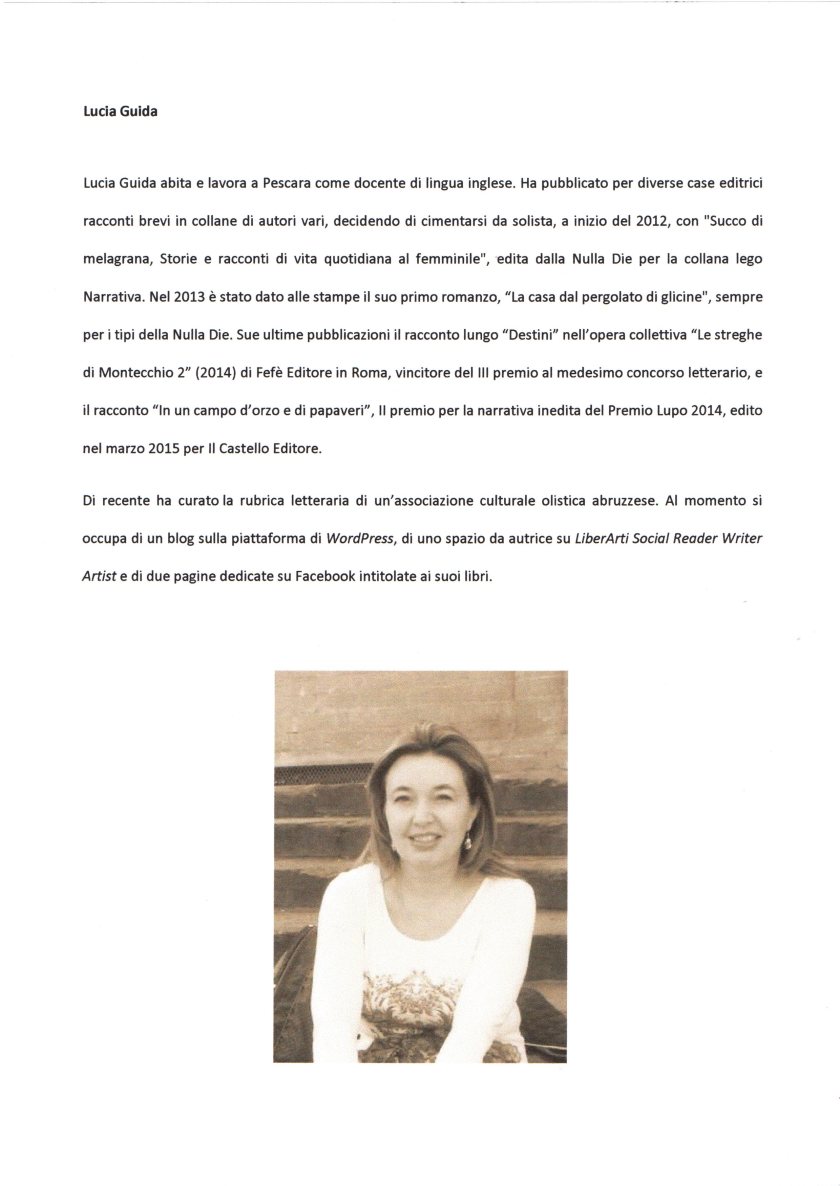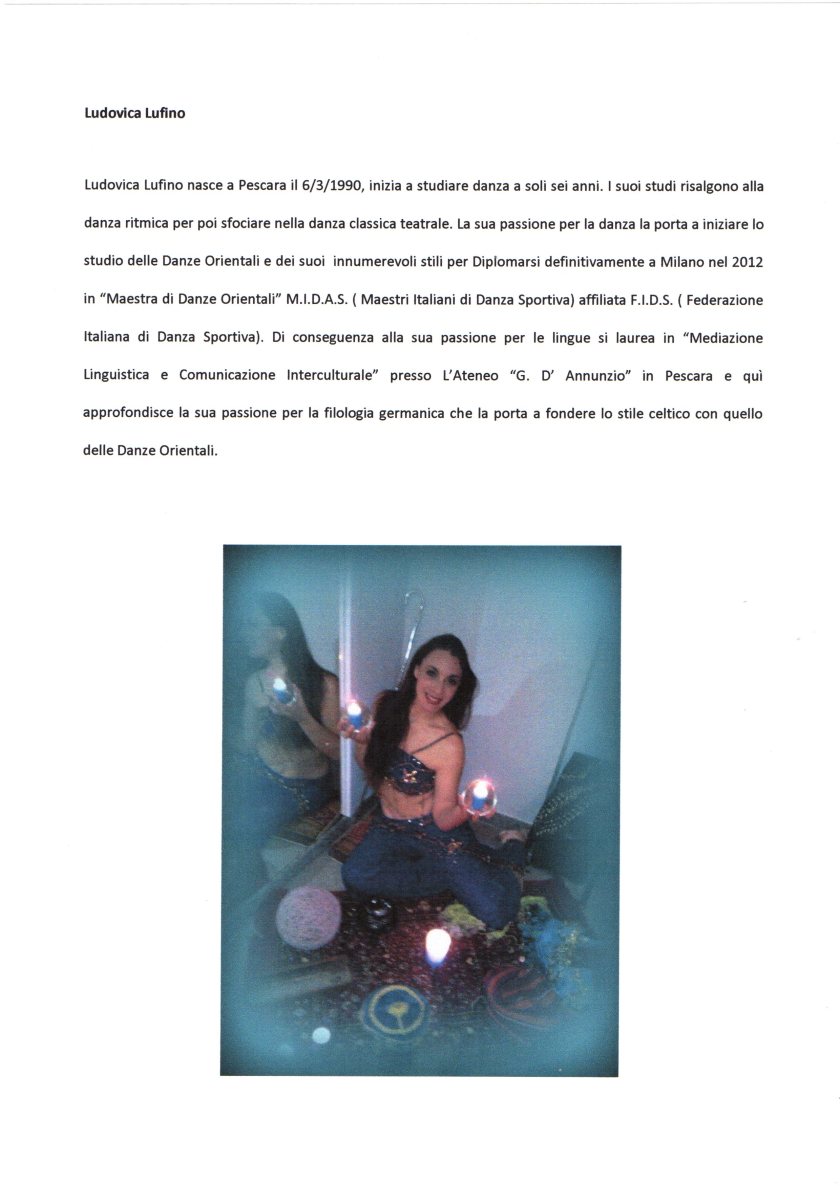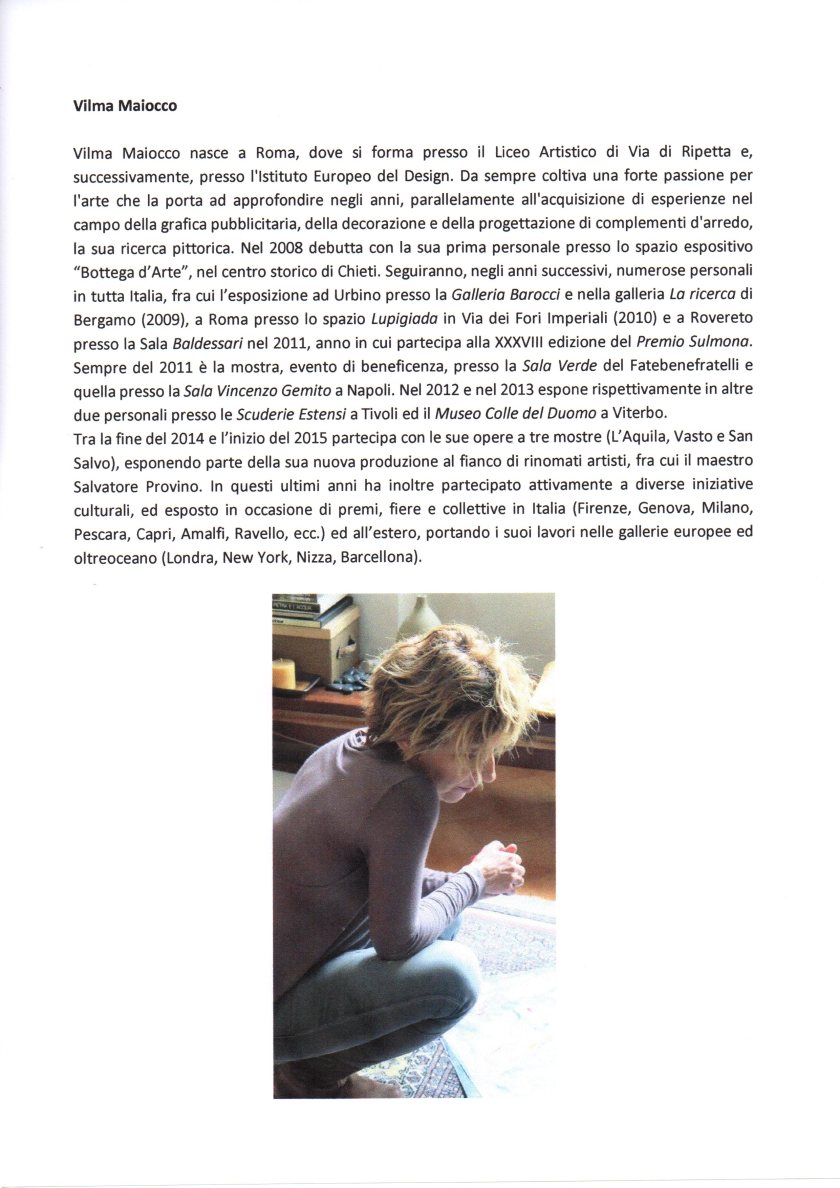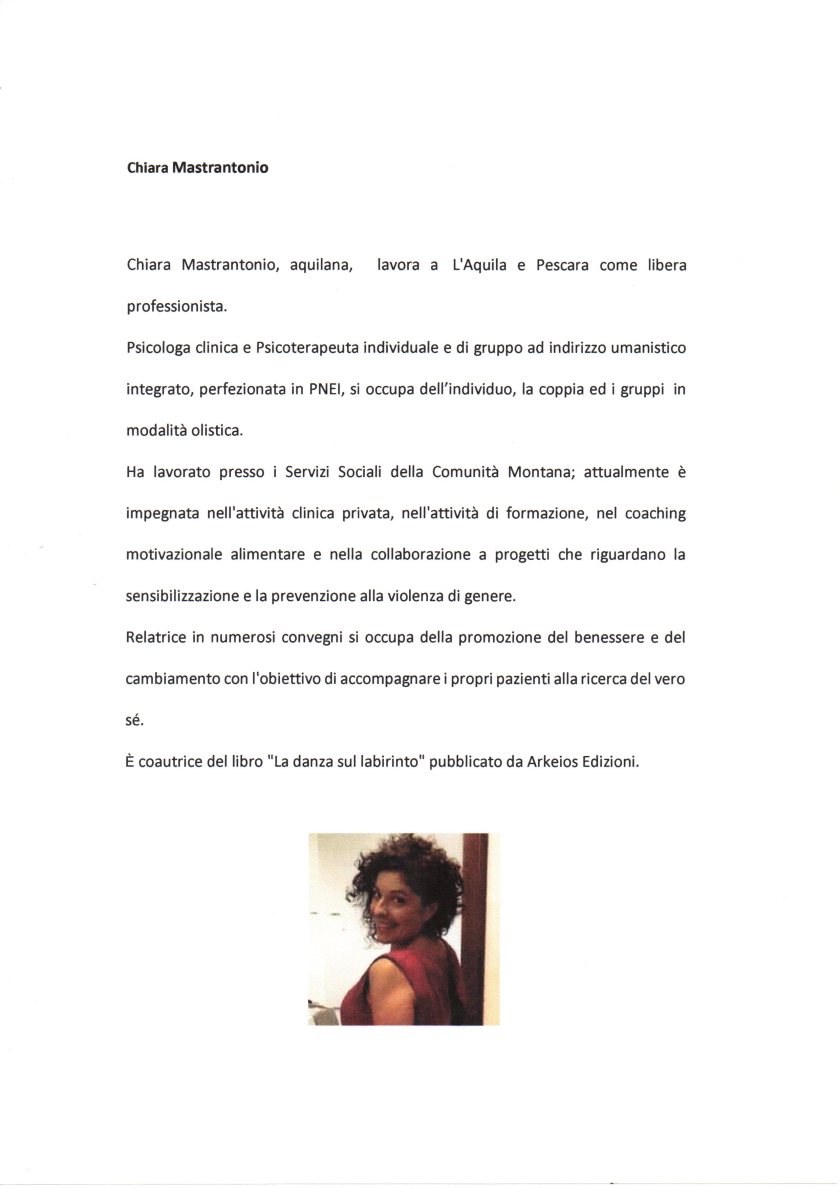Nell’attesa che la questione dei cookies di profilazione venga chiarita anche per quei blog che, come questo, non dovrebbero utilizzarne, volevo postare uno dei miei racconti scritto a progetto per un concorso letterario ma non per questo meno sentito.
Si intitola “In fondo al mare” ed è la storia di Samia Yusuf Omar, atleta somala (aveva partecipato alle Olimpiadi di Pechino nel 2008) annegata a Lampedusa nel 2012 tentando di raggiungere prospettive di vita migliori e la possibilità di poter partecipare anche alle Olimpiadi di Londra.
Una storia emblematica e tragica che ce ne riporta alla memoria tantissime altre a noi vicine: le vicissitudini dei molti italiani emigrati alla fine del XIX secolo e per buona parte del XX. Partiti alla ricerca di un’esistenza diversa, più umana ben al di là della mera concretizzazione di un sogno.
Buona lettura e a presto
Lucia
In fondo al mare*
Ho sempre amato il mare, con quell’idea di immenso e di apertura racchiusi in una promessa grigioverde.
L’ho intravisto a occhi chiusi nelle mie notti silenziose trascorse a Bondere, respingendo la polvere sottile e penetrante che la brezza solleva dalla strada, respirata assieme alla frescura e alla speranza di un’alba finalmente luminosa, beneaugurante.
Mi sono immaginata a riva, in piedi sulla battigia, ad aspettare con pazienza un barcone dal colore indefinito, prima che si riempia di noi migranti e dei nostri fardelli pesanti, scomodi. Dei nostri poveri abiti a coprire corpi affastellati gli uni agli altri in una bizzarra composizione cromatica in cui, quasi per caso, si mescolano sfumature pacate a colori brillanti.
Su un carretta del mare non c’è posto per molti oggetti.
A mala pena ci è permesso di portare un sogno ciascuno. Io ne ho uno speciale. Tendere il mio corpo esile e aggraziato in avanti, scattando dopo il segnale di partenza con la determinazione e l’agilità di una gazzella: finalmente verso la libertà e la possibilità concreta di sperare in qualcosa di bello senza dovermi guardare dalla paura di non farcela per la disapprovazione e il disprezzo della mia gente.
Per molti io sono soltanto una donna e le mie braccia tese nello sforzo di far bene, controbilanciando con sapienza e perizia la forza di gravità del mio corpo esile in corsa, potranno semplicemente stringersi a un uomo durante l’amore o serrare a sé un bambino per allattarlo.
Io voglio di più.
Voglio sfinirmi nella durezza di un allenamento quotidiano mettendomi alla prova per potercela fare, lo desidero per me stessa e per tutti quelli che hanno creduto in me. Per l’amore e l’affetto di coloro che mi hanno sempre sostenuta e che ora non ci sono più, e anche per quelli a cui è mancata la forza e la volontà di lottare, e che pure mi hanno incitata, con le loro ultime parole, ad andare via.
Verso un nonluogo, una terra promessa che non oso immaginare e che non sarà mai la casa che mi ha vista nascere e combattere sin dal mio primo vagito ma che spero potrà accogliermi con sufficiente benevolenza. Da principio, forse, con curiosità silenziosa, poi con crescente rispetto per la mia volontà di riscatto. Mia e di tutte quelle donne che hanno pensato di non farcela, smettendo di interrare un desiderio possibile nell’arida sabbia del deserto e di attenderne il minuscolo germoglio verde, primo passo verso una vita finalmente degna di essere vissuta.
Il dondolio di questo barcone stipato di gente e di sospiri appena accennati mi stordisce piano.
Sono stanca e cerco di recuperare le poche forze che mi restano pensando a qualcosa di bello dopo un tragitto lunghissimo attraverso Etiopia, Sudan e Libia: un ricordo d’amore lontano intriso di sensualità e passione; il viso di mio padre, mio primo mentore; la felicità che proverò quando riabbraccerò mia sorella. Con lei potrò parlare ancora fino a notte tarda e tirare l’alba intessendo progetti e ridendo al pensiero di momenti lontani fatti di piccole gioie ricavate con esercizio paziente di positività. Riunite finalmente per volontà di Allah e per nostra determinazione terrena.
Il cielo è ancora indefinito e non sa dare risposte. A lui si sostituisce la protervia dell’uomo, sempre pronta a fornirle.
Nelle acque di questo paese, l’Italia, prima porta verso una riconquistata dignità, ci intimano l’alt. Non vogliono farci sbarcare ma la carretta del mare che ci ha accolti non ha più forza per trattenerci, stentando a navigare dopo gli innumerevoli viaggi sostenuti.
Anch’io mi sento stanca e non ho alternative a cui pensare. Socchiudo gli occhi, appannati e indeboliti dalla salsedine di giorni e giorni di navigazione, cercando di focalizzare con tutta me stessa la sagoma scura, all’apparenza così vicina, dell’isola di Lampedusa, fantasticando che sia una specie di striscione di “arrivo” di una competizione ben lontana dall’essere terminata, tentata con la forza della disperazione.
E’ il momento di agire e mi costringo a tornare vigile. Attorno a me molti hanno smesso di lottare, facendo calare sui volti impassibili, già martoriati da ogni tipo di sofferenza materiale e psichica, una maschera silenziosa di indifferenza.
Ora so cosa fare.
Inspiro profondamente prima di tentare il rush finale. Poi mi getto in acqua.
La prima sensazione è di gelo infinito, paralizzante, che mi toglie il fiato. Cerco di concentrarmi come in una delle tante gare sull’attimo presente, scacciando via qualsiasi cosa possa fungere da zavorra. Ho bisogno di tutta me stessa per farcela e so che stavolta non avrò grida amorevoli d’incoraggiamento a sostenermi.
Il cielo è sereno ma non riesco a scommettere sulla sua sincerità.
Decido di puntare tutto su un capo di fune sottile ma robusta che un marinaio giovane e compassionevole ha lanciato da un peschereccio verso di me a pochi metri. Non mangio da tre giorni e l’ultima goccia d’acqua assaporata è stata il regalo di ieri di un vecchio rugoso che non ha voluto lasciare il ponte dell’imbarcazione, stringendosi al parapetto scrostato per scrutare noi temerari. Nuoto con lentezza, consapevole delle forze che mi stanno abbandonando e per la concentrazione che metto in quest’ultimo gesto. Il polpaccio destro comincia a farmi male, l’acqua fredda la fa da padrone sull’agilità e sulla prontezza dei miei movimenti. Decido di fermarmi per un solo istante. Un solo attimo, un solo respiro, una sola memoria, una sola parola.
Nel mio cuore affaticato c’è ancora tanto sole; non abbastanza, tuttavia, per avere il sopravvento sul mio corpo affranto.
A un passo da me quella corda intrisa d’acqua salmastra sta cominciando ad affondare. Mi tendo in avanti come per spiccare il volo ma non è abbastanza per afferrarla, non ce la faccio.
Il mio braccio proteso verso l’alto è un ramo scarno di un’acacia nelle strade della mia Mogadiscio: sottile e affusolato, slanciato verso il cielo.
Nello stato di gran quiete in cui sono precipitata riesco ancora a percepire il grido dapprima deciso, poi stranito e quasi disperato del mio salvatore italiano che non vuol smettere di puntare sulla mia vita. L’acqua del mare che ora mi avvolge per intero trattenendomi a sé ha lo stesso sapore salato delle lacrime che gli sono spuntate. Con uno sforzo incredibile decido di sorridere. Di dedicargli l’ultimo guizzo felice che mi resta. In fondo se lo merita, ha creduto in me e nella mia voglia di vivere, scommettendo sino all’ultimo istante sulla mia fragile salvezza.
In alto il sole ha deciso alla fine di spuntare.
Sarà una giornata mite e gloriosa per molti ma non per me.
Priva di energia scivolo con dolcezza in fondo al mare, perdendomi nel suo verde intenso sfumato di blu. A occhi aperti cerco di vincere l’oscurità che mi assale, guardando verso l’alto, verso l’ultimo raggio di luce che non è riuscito a trattenermi. So di essere al capolinea, ne sono spaventata ma avverto anche un senso di liberazione, una sorta di pacata rassegnazione
Questa terra che non mi ha voluta sarà il mio ultimo scrigno.
Nel silenzio ovattato che ora mi circonda mi sembra di udire ancora il dispiacere autentico di quell’uomo di mare giovane dal cuore palpitante come unica forma di riscatto e tardivo atto d’amore per me. A lui va la mia ultima benedizione.
Ti libero dal mio ricordo e dalla mia immagine, dal mio carico di frutti ingombranti e troppo preziosi. Pensami per il solo istante di questa giornata di Primavera fugace. Pesca per la tua gente e per le persone a te care. Lotta per la tua felicità quotidiana respirando a polmoni ampi. Centellina con parsimonia il tuo Tempo senza sprecarne un nanosecondo. Ama e fatti amare.
Lampedusa, 2 aprile 2012
*A Samia Yusuf Omar
Lucia Guida

Photo Credit: Repubblica.it